
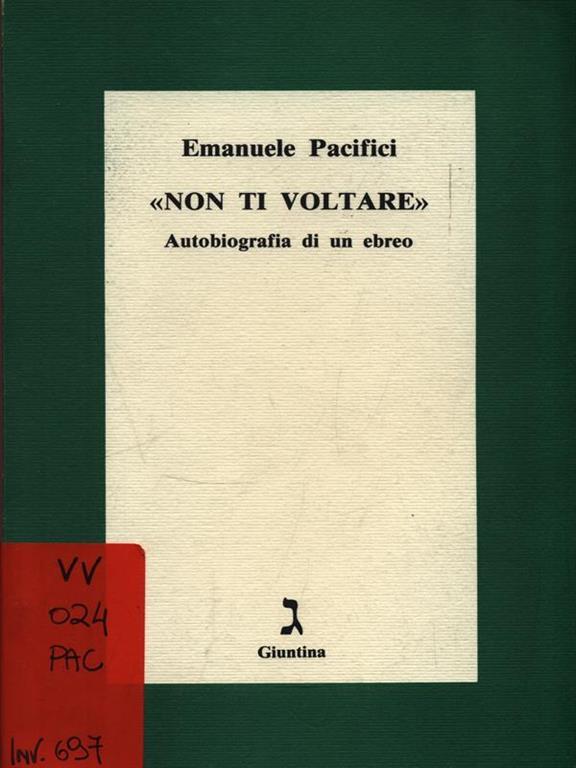
|
Emanuele
Pacifici Non
ti voltare (...) Quando lo zio venne a prendere
me e Raffaele, la mamma ci accompagnò fino al portone; si raccomandò a me in
particolare di fare il bravo e di obbedire a chi si sarebbe preso cura di noi;
poi una carezza, un bacio dato in fretta, e sparì dietro la grande vetrata bianca. Lo strazio della
separazione era tutto dentro di noi, inespresso. Lo zio ci accompagnò a Settignano nel collegio
di Santa Marta, ma non eravamo sicuri di essere accettati. Fortunatamente suor
Marta Folcia, che faceva le veci della superiora momentaneamente indisposta, ci
disse che potevamo rimanere e dopo aver
brevemente parlato con lo zio, rivolgendosi a me e
Raffaele disse: «Allora ragazzi, salutate vostro zio e andate subito a mangiare
nella sala del refettorio». Era la
domenica 21 novembre 1943: il mio destino mi imponeva ancora una volta una
separazione dai miei cari, ancora una volta un ambiente estraneo. Ora mi
sarebbe stato imposto di cambiare perfino identità; la mattina dopo infatti
suor Marta venne in classe e, davanti
a tutti gli altri ragazzi, disse eh il mio cognome era Pallini, mentre
Pacifici era solo un soprannome datomi in famiglia a causa della mia
tranquillità, e con voce severa aggiunse: «In questo istituto non possiamo
ammettere dei soprannomi!». Da quel giorno io e mio fratello diventammo i
fratelli Pallini. A guerra finita, prima di lasciare il collegio, seppi che la
suora si era accorta che nelle nostre tessere annonarie era stato scritto per
errore Pallini e lei pensò bene di cogliere la palla al balzo. Il venerdì 26 novembre, la mamma telefonò a
suor Marta dicendo che la domenica pomeriggio sarebbe venuta a trovarci. Quella
domenica la passai appoggiato alla finestra ad aspettare il filobus che si
fermava proprio davanti al collegio. Alle sei, quando ormai era già buio e
l'ora di andare in chiesa, le suore riuscirono solo a fatica ad allontanarmi
singhiozzante da quella finestra. Suor Marta cercò di consolarmi dicendomi che
se la mamma non era venuta, voleva dire che qualche cosa glielo aveva impedito.
La domenica seguente attesi di nuovo inutilmente tutto il giorno e quando fu
sera il mio pianto divenne irrefrenabile e cominciai a gridare che volevo la
mia mamma. Alcune suore mi si fecero intorno e dopo avermi calmato riuscirono a
mettermi a letto. Passarono quindici interminabili giorni,
poi una mattina suor Marta mi mandò a chiamare e mi comunicò che nella notte
tra sabato 26 e domenica 27 novembre il convento delle suore del Carmine era
stato perquisito dai soldati delle SS e aggiunse: «Anche la mamma ha subìto la
stessa sorte di vostro padre». La
notizia mi fu data nell'atrio dell'istituto, di fronte alla vetrata che porta
nella cappella. La suora poi, con lo stesso tono formale, mi invitò ad andare a
pregare insieme a lei. Non piansi, ma capii che da quel momento io e mio
fratello di appena cinque anni eravamo soli al mondo, senza più l'affetto dei
nostri genitori che ci erano stati strappati da coloro che or mai da anni
seminavano lutto e terrore in Europa. Così anche la mamma fu deportata ad
Auschwitz, con lo stesso convoglio di papà. Chissà se si videro... Chi mai
avrebbe pensato che il bacio, la carezza che la mamma ci aveva da to quella
domenica salutandoci sarebbero stati gli ultimi. Come potevo immaginare che la
benedizione di mio padre, sulla panchina della stazione, era il suo addio? Il
vuoto, la solitudine lasciati dalla perdita dei miei genitori erano senza fine:
niente e nesst1no avrebbe potuto alleviarli, ma non c'era neppure nessuno
accanto a me che volesse tentare di farlo. E per Raffaele che era più piccolo,
se è possibile fu ancora peggio che per me. Il trauma fu tale che per tutta la
vita rifiutò di par lare dei nostri genitori. Solo una volta mi disse che
della mamma gli restava come un'ombra davanti, mentre di nostro padre non
ricordava niente. Passammo nove interminabili mesi nel collegio
di Santa Marta nella continua incertezza di cosa ci avrebbe riservato
l'indomani. Si combatteva anche a Settignano e la piazza principale era un
cumulo di macerie. Nel collegio la stanza della dispensa era stata trasformata
in rifugio e l'entrata era ben protetta con i sacchetti di sabbia. Di fronte
c'era una quercia secolare che fortunatamente un giorno ci fece da scudo contro
un proiettile di cannone che altrimenti ci avrebbe colpito. Ancora oggi la
quercia è là, verdeggiante, e nel suo grande tronco è rimasta a testimonianza
una scheggia di quel proiettile.
|