
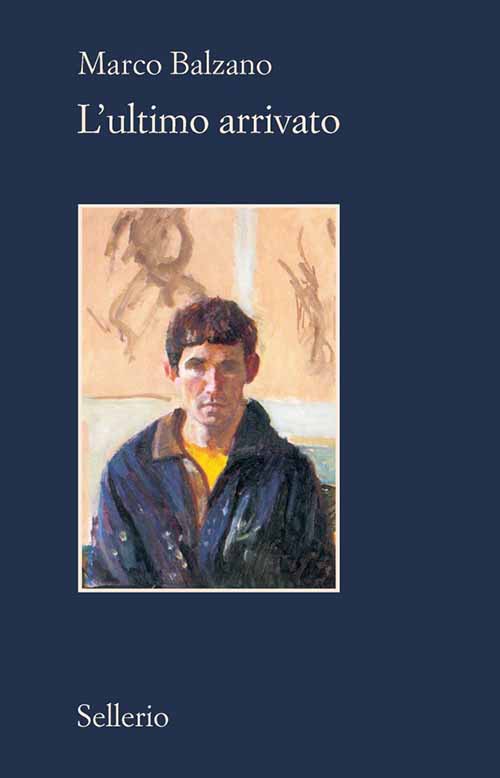
|
L’ultimo
arrivato Marco
Balzano
Una volta le ho prese pure perché sono andato a
scuola. Mio padre, siccome la sera non mi aveva dato da mangiare, disse che
potevo alzarmi più tardi. Così al risveglio pensai che non era più orario di
jurnataru e senza dire niente presi per via dei Ginepri. Dalla contentezza mi
fermai a chiedere in regalo un tarallo al forno di via Ruggero il Normanno. Da
picciriddu sapevo fare di quegli occhi dolci! Anche farmi venire le lacrime
finte sapevo, come un attore di Cinecittà. Le signore, infatti, ci cascavano
sempre. Adesso invece ho questi occhi stretti stretti, a fessura, che sembra
che hanno litigato col sole. Quel giorno di scuola ancora oggi non lo posso
dimenticare. Appena entrato in classe, una delusione. Mi aspettavo una festa
come quella del santo e invece, a parte Peppino che saltellava come un
coniglio, nessuno mi considerò. Sembrava che non ero mai mancato. Solo Ettore
venne a supplicarmi di non rubargli la merenda e di nuovo si mise a piangere
come una femminuccia. Anche il maestro Vincenzo, quando entrò, non mi rivolse
parola. Vedendomi seduto al mio posto corrugò la fronte, ma niente di più. Io
allora pensai che la nostra amicizia era agli sgoccioli e me ne volevo scappare
di corsa in campagna. Fece una lezione coi fiocchi, il maestro. Parlò di un
signore che si chiamava Giangiacomo Russò e lo chiamò pensatore, una parola che
non avevo mai sentito e che secondo il mio compagno di banco significava uno
molto intelligente e che la sa lunga, mentre secondo Peppino indicava uno che
il mattino si alza e non tiene una minchia da fare. Il maestro fece un disegno
alla lavagna: due uomini. Uno stava in mezzo a un campo recintato e diceva
«questo è mio!», l’altro stava in un campo senza recinto e non diceva niente.
Il maestro ci fece ricopiare il suo disegno e poi spiegò che prima che
quell’uomo dicesse «questo è mio!» non esisteva la società – caserme, ospedali,
scuole, tribunali, carceri, banche – e tutti vivevano liberi, la natura era
così generosa che ciò che cresceva spontaneamente bastava e non c’era bisogno
di scannarsi per un boccone. Però poi quello disse «questo è mio!» e allora chi
si è visto si è visto. Ognuno iniziò a imitarlo e al posto che sognare un
paesaggio o una bella femmina iniziò a sognare recinti sempre più alti e mise
porte con la serratura alle case e cani feroci ai cancelli. «Russò scrive che
questa invenzione dei recinti si chiama proprietà privata» disse il maestro.
Peppino alzò la mano per chiedere se questo signore era uno che nella vita
russò molto e fece un grugnito col naso che ancora mi fa ridere a pensarci,
sento nella testa un coro gioioso di picciriddi. |